La sera del 18 dicembre 2004, nella frazione di Madiran, nel sud-ovest della Francia, un uomo di nome Jean-Luc Josuat-Vergès vagava nelle gallerie di una fattoria di funghi abbandonata e si è perso. Josuat-Vergès, che aveva 48 anni e lavorava come custode in un centro sanitario locale, era depresso. Lasciando sua moglie e suo figlio di 14 anni a casa, aveva guidato fino alle colline con una bottiglia di whisky e una tasca piena di sonniferi. Dopo aver guidato la sua Land Rover nel grande tunnel d’ingresso della fattoria dei funghi, aveva acceso la sua torcia e si era addentrato nel buio.
I tunnel, che erano stati originariamente scavati nelle colline calcaree come miniera di gesso, comprendevano un labirinto di cinque miglia di corridoi ciechi, passaggi tortuosi e vicoli ciechi. Josuat-Vergès percorse un corridoio, girò, poi girò ancora. La batteria della sua torcia si affievolì lentamente, poi morì; poco dopo, mentre percorreva un corridoio fradicio, le sue scarpe furono risucchiate dai suoi piedi e inghiottite dal fango. Josuat-Vergès inciampò a piedi nudi nel labirinto, brancolando nel buio pesto, cercando invano l’uscita.
Il pomeriggio del 21 gennaio 2005, esattamente 34 giorni dopo che Josuat-Vergès era entrato per la prima volta nelle gallerie, tre adolescenti del posto decisero di esplorare la fattoria di funghi abbandonata. A pochi passi nel buio corridoio d’ingresso, hanno scoperto la Land Rover vuota, con la porta del conducente ancora aperta. I ragazzi hanno chiamato la polizia, che ha prontamente inviato una squadra di ricerca. Dopo 90 minuti, in una camera a soli 600 piedi dall’ingresso, hanno trovato Josuat-Vergès. Era di un pallore spettrale, magro come uno scheletro, e si era fatto crescere una lunga barba incolta, ma era vivo.
Nei giorni seguenti, quando la storia della sopravvivenza di Josuat-Vergès raggiunse i media, divenne noto come le miraculé des ténèbres, “il miracolo delle tenebre.”
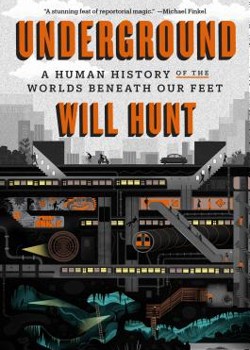
Regalava i giornalisti con le storie delle sue settimane nella fattoria dei funghi, che sembravano rivaleggiare anche con i più grandiosi racconti di alpinisti bloccati o di naufraghi su isole deserte. Mangiava argilla e legno marcio, che trovava strisciando a quattro zampe e scalpitando nel fango; beveva l’acqua che gocciolava dal soffitto di pietra calcarea, a volte anche succhiando l’acqua dalle pareti. Quando dormiva, si avvolgeva in vecchi teloni di plastica lasciati dai coltivatori di funghi. La parte della storia di Josuat-Vergès che confondeva i giornalisti era che aveva subito oscillazioni radicali e inaspettate nel suo umore.
Altre storie
A volte, come ci si poteva aspettare, sprofondava in una profonda disperazione; da un pezzo di corda che aveva trovato, aveva persino fatto un cappio, “nel caso le cose diventassero insopportabili”. Ma in altri momenti, ha spiegato Josuat-Vergès, mentre camminava nel buio, scivolava in una sorta di calma meditativa, permettendo ai suoi pensieri di ammorbidirsi e srotolarsi, mentre abbracciava le sensazioni di disorientamento, lasciandosi galleggiare attraverso i tunnel in un pacifico distacco. Per ore e ore, mentre vagava per il labirinto, disse: “Ho cantato da solo nel buio”
L’homo sapiens è sempre stato un meraviglioso navigatore. Possediamo un potente organo nella regione primitiva del nostro cervello chiamata ippocampo, dove, ogni volta che facciamo un passo, un milione di neuroni raccoglie dati sulla nostra posizione, compilando quella che i neuroscienziati chiamano una “mappa cognitiva”, che ci mantiene sempre orientati nello spazio. Questo robusto apparato, che supera di gran lunga le nostre esigenze moderne, è un hand-me-down dai nostri antenati cacciatori-raccoglitori nomadi, la cui sopravvivenza dipendeva dai poteri di navigazione. Per centinaia di migliaia di anni, l’incapacità di localizzare una pozza d’acqua o un rifugio roccioso sicuro, o di seguire le mandrie di selvaggina e individuare le piante commestibili, avrebbe portato a morte certa. Senza la capacità di pilotarci attraverso paesaggi sconosciuti, la nostra specie non sarebbe sopravvissuta – è intrinseca alla nostra umanità.
Leggi: Quando il cervello non riesce a creare le proprie mappe
Non è una sorpresa, quindi, che quando perdiamo l’orientamento, veniamo gettati in un panico primordiale e amaro in bocca. Molte delle nostre paure più elementari – essere separati dai nostri cari, sradicati da casa, lasciati al buio – sono permutazioni della paura di perdersi. Nelle nostre fiabe, è quando la bella fanciulla si disorienta nella foresta oscura che viene avvicinata dal troll minaccioso o dalla strega incappucciata. Anche l’inferno è spesso rappresentato come un labirinto, risalendo a Milton, che fece il paragone nel Paradiso Perduto. L’archetipo della storia horror del disorientamento è il mito greco del Minotauro, che abita nelle tortuose pieghe del Labirinto di Cnosso, una struttura, come scrisse Ovidio, “costruita per diffondere l’incertezza”, per lasciare il visitatore “senza un punto di riferimento”
Talmente radicata è la nostra paura del disorientamento che perdersi potrebbe innescare una sorta di crack-up, dove il nostro stesso senso di sé va in pezzi. “Per un uomo totalmente disabituato”, scrisse Theodore Roosevelt nel suo libro del 1888 Ranch Life and the Hunting Trail, “la sensazione di perdersi nella natura selvaggia sembra portarlo in uno stato di terrore panico che è spaventoso da vedere, e che alla fine lo rende privo di ragione … Se non viene trovato in tre o quattro giorni, è molto incline a diventare pazzo; poi fuggirà dai soccorritori, e deve essere inseguito e catturato come se fosse un animale selvatico.”
Dal nostro primo passo nelle tenebre sotterranee, il nostro ippocampo, che ci guida in modo così affidabile nel mondo di superficie, va in tilt, come una radio che ha perso la ricezione. Siamo tagliati fuori dalla guida delle stelle, dal sole e dalla luna. Persino l’orizzonte svanisce: se non fosse per la gravità, a malapena distingueremmo l’alto dal basso. Tutti gli indizi sottili che potrebbero orientarci in superficie – formazioni di nuvole, modelli di crescita delle piante, tracce di animali, direzione del vento – scompaiono. Nel sottosuolo, perdiamo anche la guida della nostra stessa ombra.
Giù, in uno stretto passaggio di grotta, o nelle pieghe delimitate di una catacomba, il nostro campo visivo ha i paraocchi, non arriva mai oltre la prossima curva o curva. Come ha osservato lo storico delle grotte William White, non si vede mai veramente tutta una grotta, ma solo una scheggia alla volta. Quando navighiamo in un paesaggio, ha scritto Rebecca Solnit in A Field Guide to Getting Lost, stiamo leggendo ciò che ci circonda come un testo, studiando “il linguaggio della terra stessa”; il sottosuolo è una pagina bianca, o una pagina scarabocchiata con un linguaggio che non possiamo decifrare.
Leggi: Terra incognita
Non che sia illeggibile per tutti. Alcune creature sotterranee sono meravigliosamente adattate a navigare nel buio. Tutti conosciamo il pipistrello, che si lancia in picchiata nell’oscurità delle caverne usando il sonar e l’ecolocalizzazione, ma il campione dei navigatori sotterranei potrebbe essere il ratto talpa cieco: una creatura rosa, rugosa e con i denti a spazzola – immaginate un pollice di 90 anni con le zanne – che trascorre le sue giornate in vasti nidi sotterranei simili a labirinti. Per navigare in questi passaggi bui, il ratto talpa cieco batte periodicamente la testa contro il terreno, poi discerne la forma dello spazio in base ai modelli delle vibrazioni di ritorno. Nel suo cervello, il ratto ha anche un piccolo deposito di ferro, una bussola incorporata, che rileva il campo magnetico terrestre. La selezione naturale non ha dotato noi abitanti della superficie di questi trucchi adattivi. Per noi, un passo sottoterra è sempre un passo nel vuoto della navigazione, un passo nella direzione sbagliata, o meglio, nessuna direzione.
In qualsiasi altro paesaggio, quando i nostri poteri innati di navigazione vacillano, ci rivolgiamo a una mappa, che ci ancorano nello spazio e ci tengono sulla rotta. Nel mondo sotterraneo, però, la mappatura è sempre stata un’impresa che lascia perplessi. Molto tempo dopo che esploratori e cartografi avevano tracciato la mappa di ogni altro paesaggio terrestre del pianeta, gettando linee pulite di griglia latitudinale e longitudinale su arcipelaghi e catene montuose remote, gli spazi direttamente sotto i nostri piedi sono rimasti inafferrabili.
La prima mappa conosciuta di una grotta è stata disegnata nel 1665 della Grotta di Baumann, una grande caverna nella regione densamente boscosa di Harz in Germania. A giudicare dalle linee rudimentali della mappa, il cartografo, un uomo identificato come Von Alvensleben, non sembra essere stato un esperto cartografo, e nemmeno uno capace, ma le lacune della mappa sono comunque notevoli. L’esploratore non è riuscito a trasmettere alcun senso di prospettiva, o profondità, o qualsiasi altra dimensione – non è riuscito a comunicare nemmeno che lo spazio è sotterraneo. Von Alvensleben stava tentando di mappare uno spazio che era neurologicamente mal equipaggiato per vedere, uno spazio letteralmente oltre la sua percezione. Arrivò al punto di una follia epistemologica, come cercare di dipingere il ritratto di un fantasma, o catturare una nuvola in una rete.
La mappa della Grotta di Baumann fu la prima di una lunga serie di curiosi fallimenti della cartografia sotterranea. Per generazioni, gli esploratori di tutta Europa – squadre di uomini coraggiosi e donchisciotteschi – hanno scavato grotte con l’intento di misurare il mondo sotterraneo, di orientarsi nel buio, solo per fallire, spesso in modi sconcertanti. Su corde logore, si calavano in profondità nel sottosuolo, dove vagavano per ore, arrampicandosi su massi enormi e nuotando lungo fiumi sotterranei. Guidavano il loro cammino con candele di cera, che emettevano deboli corone di luce che si estendevano non più di qualche metro in ogni direzione. I topografi ricorrevano spesso a misure assurde, come un esploratore austriaco di nome Joseph Nagel che, nel tentativo di illuminare la camera di una grotta, legò una serie di candele ai piedi di due oche, poi lanciò dei sassolini alle oche, sperando che prendessero il volo e gettassero la loro luce attraverso il buio. (Non funzionava: le oche barcollavano e cadevano a terra.)
Anche quando riuscivano a fare delle misurazioni, nel frattempo, la percezione spaziale degli esploratori era così distorta dai capricci dell’ambiente che i loro risultati erano completamente sbagliati. In una spedizione del 1672 in Slovenia, per esempio, un esploratore scandagliò un tortuoso passaggio in una grotta e ne registrò la lunghezza in sei miglia, quando in realtà aveva percorso solo un quarto di miglio. I rilievi e le mappe emerse da queste prime spedizioni erano spesso così divergenti dalla realtà che alcune grotte sono ora effettivamente irriconoscibili. Oggi, possiamo leggere i vecchi rapporti solo come piccole, misteriose poesie su luoghi immaginari.
Il più famoso dei primi mappatori di grotte fu un francese della fine del XIX secolo, Edouard-Alfred Martel, che sarebbe diventato noto come il padre della speleologia. Nel corso di una carriera di cinque decenni, Martel guidò circa 1.500 spedizioni in 15 paesi del mondo, centinaia delle quali in grotte vergini. Avvocato di professione, ha trascorso i suoi primi anni a calarsi nel sottosuolo in maniche di camicia e cappello a bombetta, prima di progettare finalmente un kit di attrezzature speleologiche specializzate. Oltre a una barca di tela pieghevole soprannominata Alligator, e un telefono da campo per comunicare con i portatori in superficie, ha ideato una batteria di strumenti di rilevamento sotterraneo. Per esempio, inventò un aggeggio per misurare una grotta da pavimento a soffitto, in cui attaccava una spugna imbevuta d’alcool a un palloncino di carta su una lunga corda, poi metteva un fiammifero sulla spugna, facendo salire il palloncino sul tetto mentre lui srotolava la corda. Le mappe di Martel potevano essere più precise di quelle dei suoi predecessori, ma in confronto alle mappe disegnate dagli esploratori di qualsiasi altro paesaggio dell’epoca, erano poco più che schizzi. Martel fu celebrato per la sua innovazione cartografica di dividere una grotta in sezioni trasversali distinte (o coupe), che sarebbe diventata lo standard nella mappatura delle grotte.
Leggi: Come le mappe digitali hanno cambiato ciò che significa perdersi
Martel e i suoi compagni esploratori, che hanno trascorso anni cercando e fallendo di orientarsi nel mondo sotterraneo, erano discepoli della perdita. Nessuno conosceva così intimamente l’esperienza sensoriale del disorientamento: Per ore e ore, fluttuavano nel buio, presi in un prolungato stato di vertigine, mentre cercavano e non riuscivano ad ancorarsi. Secondo tutta la logica evolutiva, dove la nostra mente è cablata per evitare il disorientamento a tutti i costi, dove lo smarrimento attiva i nostri recettori di paura più primitivi, devono aver provato una profonda ansia: “il terrore panico che è spaventoso da vedere”, come lo descrisse Roosevelt. E tuttavia, sono scesi ancora e ancora.
Hanno tratto una forma di potere, sembra, dal perdersi nel buio.
La perdita è sempre stata uno stato enigmatico e multiforme, sempre pieno di potenze inaspettate. Nel corso della storia, tutte le varietà di artisti, filosofi e scienziati hanno celebrato il disorientamento come motore della scoperta e della creatività, sia nel senso di allontanarsi da un percorso fisico, sia nel deviare dal familiare, verso l’ignoto.
Per fare grande arte, diceva John Keats, bisogna abbracciare il disorientamento e allontanarsi dalla certezza. Lo chiamava “capacità negativa”: “cioè, quando un uomo è capace di stare nelle incertezze, nei misteri, nei dubbi, senza alcun irritabile inseguimento del fatto e della ragione”. Anche Thoreau descrisse lo smarrimento come una porta per comprendere il proprio posto nel mondo: “Non finché non siamo completamente persi, o girati”, scrisse, “non apprezziamo la vastità e la stranezza della natura… Non finché non siamo persi, in altre parole, non finché non abbiamo perso il mondo, cominciamo a trovare noi stessi, e a realizzare dove siamo e l’infinita estensione delle nostre relazioni”. Tutto questo ha senso, neurologicamente parlando: In uno stato di disorientamento, i neuroni del nostro ippocampo raccolgono freneticamente ogni suono, odore e vista nel nostro ambiente, alla ricerca di qualsiasi dato che possa aiutarci a ritrovare l’orientamento. Anche se ci sentiamo ansiosi, la nostra immaginazione diventa prodigiosamente attiva, evocando immagini ornate dal nostro ambiente. Quando prendiamo una svolta sbagliata nel bosco e perdiamo di vista il sentiero, la nostra mente percepisce ogni schiocco di ramoscello o fruscio di foglie come l’arrivo di un orso nero irascibile, o un branco di facoceri, o un galeotto in fuga. Proprio come le nostre pupille si dilatano in una notte buia per ricevere più fotoni di luce, quando ci siamo persi, la nostra mente si apre al mondo in modo più completo.
Alla fine degli anni ’90, un team di neuroscienziati ha rintracciato il potere del disorientamento fino agli ornamenti fisici del nostro cervello. In un laboratorio dell’Università della Pennsylvania, hanno condotto esperimenti su monaci buddisti e suore francescane, dove hanno scansionato i loro cervelli durante la meditazione e la preghiera. Immediatamente, hanno notato un modello: In uno stato di preghiera, una piccola regione vicino alla parte anteriore del cervello, il lobo parietale superiore posteriore, ha mostrato un calo di attività. Questo particolare lobo, come si è scoperto, lavora strettamente con l’ippocampo nei processi di navigazione cognitiva. Per quanto i ricercatori hanno potuto vedere, l’esperienza di comunione spirituale era intrinsecamente accompagnata dall’ottundimento della percezione spaziale.
Non dovrebbe essere una sorpresa, quindi, che gli antropologi hanno rintracciato una sorta di culto della perdita che attraversa i riti religiosi del mondo. Lo studioso britannico Victor Turner ha osservato che ogni rito sacro di iniziazione procede in tre fasi: separazione (l’iniziato si allontana dalla società, lasciandosi alle spalle il suo precedente status sociale), transizione (l’iniziato è nel mezzo del passaggio da uno status al successivo), e incorporazione (l’iniziato ritorna alla società con un nuovo status). Il perno si verifica nella fase centrale, che Turner chiama lo stadio della liminalità, dal latino limin, che significa “soglia”. Nello stato liminale, “la struttura stessa della società è temporaneamente sospesa”: Galleggiamo nell’ambiguità e nell’evanescenza, dove non siamo né un’identità né l’altra, no-longer-but-not-yet. Il catalizzatore ultimo della liminalità, scrive Turner, è il disorientamento.
Tra i molti rituali di smarrimento praticati dalle culture di tutto il mondo, uno particolarmente toccante è osservato dai nativi americani del Pit River in California, dove, di tanto in tanto, un membro della tribù “va a vagare”. Secondo l’antropologo Jaime de Angulo, “il Vagabondo, uomo o donna, evita gli accampamenti e i villaggi, rimane in luoghi selvaggi e solitari, sulle cime delle montagne, in fondo ai canyon”. Nell’atto di arrendersi al disorientamento, dice la tribù, il vagabondo ha “perso la sua ombra”. Andare a vagare è uno sforzo mercuriale, una pratica che può sfociare in una disperazione irrimediabile, o addirittura nella follia, ma che può anche portare un grande potere, poiché il vagabondo emerge dallo smarrimento con una chiamata sacra, prima di tornare alla tribù come sciamano.
Il veicolo più onnipresente dello smarrimento rituale – l’incarnazione più elementare del disorientamento – è il labirinto. Troviamo strutture labirintiche in ogni angolo del mondo, dalle colline del Galles alle isole della Russia orientale ai campi dell’India meridionale. Un labirinto funziona come una sorta di macchina della liminalità, una struttura ideata per progettare un’esperienza concentrata di disorientamento. Quando entriamo nei tortuosi passaggi di pietra e rivolgiamo la nostra attenzione al percorso delimitato, ci disconnettiamo dalla geografia esterna, scivolando in una sorta di ipnosi spaziale, dove tutti i punti di riferimento vengono meno. In questo stato, siamo pronti a subire una trasformazione, dove passiamo tra status sociali, fasi della vita o stati psichici. In Afghanistan, per esempio, i labirinti erano il centro dei rituali matrimoniali, dove una coppia solidificava la propria unione nell’atto di navigare il tortuoso percorso di pietra. Le strutture labirintiche nel sud-est asiatico, nel frattempo, erano usate come strumenti di meditazione, dove i visitatori camminavano lentamente lungo il sentiero per approfondire la loro concentrazione interiore. Infatti, il racconto archetipico di Teseo che uccide il Minotauro a Creta è in definitiva una storia di trasformazione: Teseo entra nel labirinto da ragazzo e ne emerge come uomo ed eroe.
Leggi: La rinascita del labirinto
Nella loro incarnazione moderna, la maggior parte dei labirinti sono bidimensionali, i loro passaggi delimitati da basse pile di pietre o da motivi a mosaico piastrellati in un pavimento. Ma se rintracciamo la stirpe del labirinto più in profondità nel passato, alla ricerca di incarnazioni sempre più antiche, troviamo le pareti che lentamente si alzano, i passaggi che diventano più scuri e più coinvolgenti – in effetti, i primi labirinti erano quasi sempre strutture sotterranee. Gli antichi Egizi, secondo Erodoto, costruirono un vasto labirinto sotterraneo, come fecero gli Etruschi nel nord Italia. La cultura pre-Inca di Chavín costruì un enorme labirinto sotterraneo in alto nelle Ande peruviane, dove conducevano rituali sacri in tunnel oscuri e sinuosi; gli antichi Maya fecero lo stesso in un oscuro labirinto nella città di Oxkintok nello Yucatán. Nel deserto di Sonoran in Arizona, nel frattempo, la tribù Tohono O’odham ha a lungo venerato un dio chiamato I’itoi, noto anche come l’Uomo nel Labirinto, che abita nel cuore di un labirinto. L’apertura del labirinto di I’itoi, un disegno spesso intessuto nei cesti tradizionali della tribù, si dice che sia la bocca di una caverna.
Quando Jean-Luc Josuat-Vergès entrò nelle gallerie della fattoria di funghi a Madiran con il suo whisky e i suoi sonniferi, aveva in mente il suicidio. “Ero depresso, avevo pensieri molto cupi”, ha detto. Dopo essere uscito dal labirinto, scoprì che aveva riacquistato il controllo della vita. Si riunì alla sua famiglia, dove si trovò più felice e più a suo agio. Iniziò a frequentare la scuola serale, ottenne una seconda laurea e trovò un lavoro migliore in una città più avanti. Quando gli è stato chiesto della sua trasformazione, ha detto ai giornalisti che mentre era nell’oscurità, “un istinto di sopravvivenza” si è attivato, rinnovando la sua volontà di vivere. Nel suo momento più buio, quando aveva disperatamente bisogno di trasformare la sua vita, ha viaggiato nell’oscurità, si è arreso al disorientamento, preparandosi ad emergere di nuovo.
Questo post è tratto dal nuovo libro di Hunt, Underground: A Human History of the Worlds Beneath Our Feet.